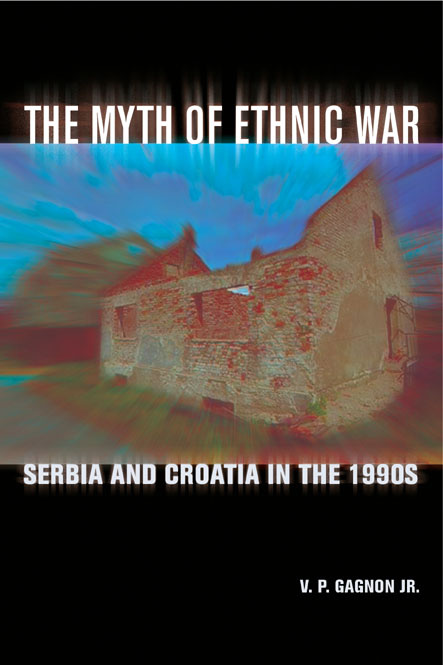Il mito della guerra etnica
Al crollo della Jugoslavia, le élite conservatrici sfruttarono il linguaggio del nazionalismo soprattutto come mezzo per restare al potere: questa è la tesi espressa da V. P. Gagnon nel libro "The Myth of Ethnic War: Serbia and Croatia in the 1990s", Jr. Cornell University Press, 2004. Una recensione da TOL
Di Florian Bieber*, per Transitions Online, 12 settembre 2005 (titolo originale: "Book Review: Beyond Ethnic")
Traduzione per Osservatorio sui Balcani: Carlo Dall’Asta
Se non era l’appartenenza etnica, che altro? Il lettore non ha bisogno di andare oltre il titolo di "The Myth of Ethnic War" per avere il sentore che l’autore suggerirà che l’appartenenza etnica non fu all’origine delle guerre degli anni ’90 nell’ex Jugoslavia. Dapprima V. P. Gagnon sembra sostenere quanto già presente in molta della letteratura pubblicata in anni recenti: le guerre in Croazia, Bosnia, e da ultimo in Kosovo non sono sorte da "antichi odii etnici" – questo vicolo cieco è già stato percorso nel corso degli anni più volte del necessario – ma sono scaturite come risultato della manipolazione della popolazione da parte delle élite politiche. Comunque, Gagnon va un passo più in là e suggerisce che i regimi in Croazia e in Serbia non entrarono in guerra allo scopo di mobilitare le masse nazionaliste o di ottenere legittimazione. Invece, egli introduce il concetto di "smobilitazione", in quanto processo attraverso cui le élite politiche scoraggiano l’attivismo politico della popolazione. La smobilitazione è perciò una tecnica a largo spettro delle élite politiche per indebolire la società civile, moderare la retorica dei partiti di opposizione e minimizzare l’impegno civico. Le "guerre autoritarie", come si potrebbe essere tentati di ridefinire la serie dei conflitti jugoslavi, erano perciò strumenti, nelle mani di quelle che Gagnon chiama "élite conservatrici", per togliere armi politiche dalle mani dell’opposizione. La sua analisi dei ricchi dati empirici lo portano a concludere che il nazionalismo non era rilevante prima dell’inizio delle guerre stesse, che le guerre non furono popolari nei due Paesi, e che i conflitti non "mobilitarono" larghe parti della popolazione in una frenesia nazionalista.
Mobilitare i "moderati"
Basandosi su numerosi sondaggi condotti da scienziati sociali jugoslavi alla fine degli anni ’80 Gagnon, che insegna all’Ithaca College nello Stato di New York e che ha prodotto diverse pubblicazioni sull’ex Jugoslavia, sostiene in modo convincente la tesi che gli stereotipi etnici e le visioni del mondo nazionaliste non erano diffuse a livello popolare, specialmente in regioni etnicamente composite della Jugoslavia come la Bosnia e parti della Croazia.
Egli ricorda come i partiti nazionalisti vinsero le elezioni del 1990 e le successive, non su una piattaforma di estremismo etnonazionalista, bensì di moderazione. Il Partito Socialista di Serbia (SPS) in particolare è un buon esempio di un partito che generalmente si posizionava politicamente al centro, con altri partiti più nazionalisti (il Movimento di Rinnovamento Serbo di Vuk Draskovic nel 1990, il Partito Radicale Serbo di Vojislav Seselj in seguito), cupi e minacciosi, che mobilitavano il sostegno ai Socialisti "moderati" di Slobodan Milosevic. Anche mentre i partiti giocavano la carta della moderazione, né l’SPS in Serbia né l’Unione Democratica Croata (HDZ) guidata da Franjo Tudjman godettero del sostegno della maggioranza assoluta della popolazione, evidenziando le limitazioni delle élite al potere. L’ipotesi che la maggior parte dei Serbi e dei Croati non volesse la guerra – "la maggioranza dei giovani, in ogni caso" – è sorretta dall’osservazione che i governi, particolarmente in Serbia, trovavano molte difficoltà a reclutare abbastanza effettivi per l’esercito. La penuria di riservisti forzò l’Esercito Popolare Jugoslavo (JNA) a rivedere i suoi ambiziosi piani riguardo alla Croazia, come l’ultimo Ministro della Difesa della Jugoslavia, Veljko Kadijevic, ammette nelle sue memorie "Moje vidjenje raspada Jugoslavije" (La mia visione del crollo della Jugoslavia): la resistenza alla leva dei giovani "divenne un importante fattore limitante nel completare i piani per impiegare il JNA, più di tutti gli altri problemi messi insieme".
La tesi di Gagnon, contro l’idea che l’appartenenza etnica fosse qualcosa di più di uno strumento impugnato dalle élite conservatrici per assicurarsi il loro mantenimento al potere, è coerente e convincente. Nel momento in cui i regimi retti da Milosevic e Tudjman finalmente si fecero da parte, a pochi mesi l’uno dall’altro, la questione etnica era divenuta secondaria, scrive Gagnon. Il controllo del potere e delle risorse non era più intrinsecamente legato allo Stato, e la "privatizzazione" del mercato a favore dei magnati vicini all’HDZ in Croazia ne era un esempio. Perciò la resistenza contro la "transizione" diminuì e il controllo delle élite conservatrici sugli organi dello Stato si allentò.
Le argomentazioni di Gagnon sono piacevolmente nuove e lucide. Il suo sfidare alcune delle convenzionali acquisizioni sull’ex Jugoslavia si ricollega ad una serie di lavori recenti, provenienti sia dalla regione che dall’esterno, come quello di Eric Gordy che in "The Culture of Power in Serbia" ha dimostrato come i leader autoritari abbiano trasformato il nazionalismo in uno strumento politico. Anche se non è difficile trovarsi d’accordo con questa tesi, sorge la domanda se questo approccio esplicatorio non attribuisca troppa influenza alle élite, trascurando la mobilitazione nazionalista tra la popolazione, precedente al successivo sfruttamento da parte delle élite.
Radicali conservatori
Gagnon si basa con forza sulla nozione di "élite conservatrici" per descrivere i circoli di governo in Serbia e in Croazia. Questi circoli in effetti crebbero in larga misura dall’ala conservatrice dei Comunisti jugoslavi. Il termine "conservatore" comunque è così ampio che difficilmente ci aiuta a comprendere la natura dell’élite che prese il potere in ciascuna delle due repubbliche. Se noi intendiamo "élite conservatrici" in opposizione a "élite democratiche" nel partito, come sostenuto negli anni ’90 da Latinka Perovic (storico e capo della Lega dei Comunisti, al potere in Serbia all’inizio degli anni ’70), troviamo anche diversi conservatori che si opposero all’ascesa dei nazionalisti. In effetti, una parte significativa delle élite in Vojvodina, Serbia e Montenegro che furono spazzate via nelle "rivoluzioni anti-burocratiche" istigate da Milosevic nel 1988 facevano parte di quella élite conservatrice, come alcuni di quelli che opposero incessanti critiche al nazionalismo in Croazia. Ciò che stupisce è perché Milosevic abbia scelto una linea politica autoritaria e nazionalista nel 1987. In quanto stella nascente nel partito, la sua carriera avrebbe potuto prendere un percorso simile a quello di Milan Kucan in Slovenia. Entrambi emersero dai ranghi come riformatori pragmatici a metà degli anni ’80, ma pur essendo entrambi sopravvissuti alla fine della Jugoslavia e del Comunismo, uno ha fatto carriera come riformatore democratico, l’altro è stato largamente responsabile per le guerre che hanno devastato la ex Jugoslavia, e infine è diventato ospite di una cella alla prigione dell’Aja. Come nota l’eccellente studio di Jasna Dragovic-Soso sugli intellettuali serbi ("Saviours of the Nation: Serbia’s Intellectual Opposition and the Revival of Nationalism", 2002), molti appartenenti delle élite liberali e riformiste si erano già convertiti al nazionalismo negli anni ’80, prima che Milosevic arrivasse al potere. Anche se certamente esistevano delle élite conservatrici, che in parte appoggiavano i programmi nazionalisti per assicurarsi il potere politico o economico, deve essere riconosciuta la forza di persuasione del nazionalismo, al di là della sua funzione di pura manipolazione. L’ascesa del nazionalismo, mai primitivo e non necessariamente destinato a sovvertire con la violenza lo stato multietnico, fino a dominare il dibattito politico alla fine degli anni ’80, non fu solo il risultato raggiunto da imprenditori etnici che sfruttarono la crescita del nazionalismo per fini politici. Quando vediamo un gruppo eterogeneo come la Chiesa Serba Ortodossa, riviste di diffusione popolare come il settimanale Duga, e il filosofo marxista Mihailo Markovic sollevare la questione del Kosovo all’inizio degli anni ’80, ciò indica una presenza più radicata del nazionalismo. Anche se la mobilitazione di massa in Serbia nel 1988 fu sicuramente bene organizzata, come dimostra Gagnon, essa indica anche una insoddisfazione generalizzata, sia di natura economica che dovuta alla frustrazione per le continue tensioni in Kosovo.
Mentre la tesi di Gagnon secondo cui i regimi non guadagnarono mai maggioranze assolute resta certamente corretta, essa non sempre collima con la sua affermazione secondo cui la moderazione dei regimi indica un minore sostegno al nazionalismo di quanto sia spesso stato suggerito. I partiti satellite e i partiti di opposizione, sia in Serbia che in Croazia, spesso sostennero un programma nazionalista più radicale ed esclusivista rispetto ai partiti dominanti. Benché i partiti collaterali, come il Partito di unità serba guidato dal comandante paramilitare Arkan, o il Partito Croato del Diritto Puro non ottennero mai molti voti, le elezioni erano spesso combattute o sulla base di linee politiche più estremiste o su quella di una "unità nazionale". Ciò suggerisce che, anche se le guerre di certo erano ampiamente impopolari, molto era condiviso nelle considerazioni di fondo sulla guerra e sulla "questione" nazionale in entrambi i Paesi.
Concetti trasformati per società trasformate
Questi spunti critici non vogliono suggerire che il meccanismo della "smobilitazione" non fosse all’opera. Cero, il libro è in generale più convincente di quegli studi che presumono l’esistenza di un nazionalismo estremo o che suggeriscono che i regimi nazionalisti si ressero sfruttando un qualche tipo di isteria di massa. Tenendo in considerazione il considerevole grado di varietà all’interno della Jugoslavia, il quadro non ha probabilmente i contorni così netti come l’autore suggerisce. In definitiva, questo libro è un’eccellente aggiunta alla letteratura sull’ex Jugoslavia, e si fa apprezzare per la sua argomentazione coerente, la prospettiva comparativa, e l’inclusione degli studi sociologici provenienti dalla regione stessa.
In una ponderata conclusione, Gagnon solleva la questione se le "soluzioni etniche", come l’accresciuta protezione dei diritti delle minoranze, come per esempio nell’Accordo di Ohrid dopo il breve conflitto tra le forze macedoni e i combattenti della minoranza albanese nel 2001, siano appropriati se ammettiamo che i conflitti non furono "guerre etniche". Questa osservazione merita sicuramente una considerazione più approfondita e più spazio di quanto il libro (o questa rivista) possano dedicarvi. Questo solleva anche un’altra questione: se le guerre non iniziano come "etniche", esse finiscono però col diventarlo? I regimi autoritari e le guerre in Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina hanno trasformato le società, il che spiega perché sia così difficile avere oggi una chiara visione retrospettiva sugli anni ’80. Gli stereotipi e le visioni nazionaliste del mondo sono spesso divenute socialmente più accettabili, nelle regioni postbelliche dell’ex Jugoslavia, di quanto non lo fossero 15 anni fa, e una nuova generazione è cresciuta nei Paesi ora divisi della regione, il che suggerisce che dopo le guerre i sistemi devono confrontarsi con una realtà radicalmente diversa.
*Florian Bieber è capo ricercatore associato non-residente presso l’European Center for Minority Issues di Belgrado, e autore di "Nationalismus in Serbien vom Tode Titos bis zum Ende der Era Milosevic" (Nationalism in Serbia from the Death of Tito to the End of the Milosevic Era), Műnster/Vienna: Lit Verlag, 2005
editor's pick
latest video

news via inbox
Nulla turp dis cursus. Integer liberos euismod pretium faucibua